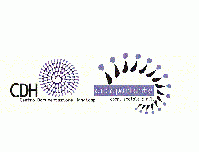di Carla Ianniello/Un giorno arriva una pandemia. Ti cade sulla testa, poi passa sulle spalle. Ti oltrepassa, cade nell’anima. Cade nella mia e in quella di tutti. E’ strano a dirsi ma forse era tempo che non ci sentivamo più tutti sulla stessa barca. Non ci prendiamo in giro si sa, non siamo tutti sulla stessa barca: alcuni ce l’hanno a remi, altri hanno motoscafi da fare invidia, altri più che barche hanno canoe. In Spagna in uno striscione su un balcone è comparsa una frase: “romanticizzare la quarantena è un privilegio di classe.” Ecco, non siamo sulla stessa barca ma stiamo navigando tutti lo stesso mare. Ed è indubbiamente un mare impervio. Ma non è un mare mosso.
Se il mare fosse una pandemia sarebbe un mare calmo, pieno di mulinelli. Il pericolo dei mulinelli non si vede. Lo senti solo quando arriva: è come il virus. Il virus non lo vedi. E’ il nemico mascherato da… Niente. Ed è per questo che ci spaventa.
Siamo abituati da anni, secoli, a guardare il pericolo e il nemico negli occhi: l’immigrato, il tossico, il criminale. Eccoli i pericoli, in fila al patibolo.
“Sparagli Pietro, sparagli ora. E dopo un colpo sparagli ancora. Fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue.” Nei versi di De Andrè non c’è il racconto del fronte, c’è altro. C’è quanto l’uomo abbia bisogno di spargere il sangue del cattivo: sui giornali, nei luoghi comuni, nelle campagne elettorali. Perché spargere il sangue del cattivo in fondo ci aiuta a immergerci in quella consapevolezza che noi siamo dalla parte giusta. Ma quell’uomo “in fondo alla valle” di cui parla De Andrè aveva solo una colpa: “la divisa di un altro colore.”
L’immigrato paga il peso della divisa col colore della pelle, il tossico col suo sguardo e i buchi sulle braccia… e il criminale, il detenuto?
Qualche tempo fa ho posto una domanda a dei ragazzi di un liceo di Bologna: “Sapreste riconoscere una persona che è stata detenuta?” La risposta è stata un secco no. E sono sicura che gli stessi ragazzi non riconoscerebbero un detenuto in permesso per le strade di Bologna.
Nell’immaginario collettivo, figlio dell’influenza dei film americani, il detenuto si immagina in divisa. Eccola “la divisa di un altro colore.” La divisa che ci permette di capire che tu sei il cattivo. Di etichettarti. Ma in Italia i detenuti non hanno divise, ma portano segni distintivi molto più pesanti. Perché oltre a macchiarsi la fedina penale, spesso ci si macchia la vita di un’esperienza che a volte porta più a ripetere gli errori che a evitarli. La vita durante e dopo il carcere è una sfida, con se stessi e con una società che fatica a comprendere che non esistono etichette. Che non esiste il buono e non esiste il cattivo. Esistono uomini che sbagliano.
Questa pandemia ci sta dicendo che il nemico non si vede e no, non ha una divisa. Che il nemico vive per le strade e non chiuso dietro le sbarre. L’isolamento sembra l’unica via per noi umani per proteggerci dalla malattia. L’umano lotta contro il virus stando da solo, evitando contatti: è un isolamento che ha un senso perché ognuno di noi è una minaccia.
I detenuti vivono in isolamento dalla società, con o senza pandemia. E’ un isolamento che ha un senso perché sono una minaccia: è un collegamento scontato. Ma le cose scontate pagano sempre un caro prezzo: non vengono pesate. Se il carcere serve a reinserire un elemento in società come narra il nostro caro art.27, ha senso isolarlo, estraniarlo dalla società stessa? Quanto questo può servire? Forse si può trarre beneficio dall’isolamento quanto prima questo diventi tentativo di convivenza. Ma la convivenza necessita di quell’elemento importante che è la fiducia reciproca. E la fiducia si sa, vive e fiorisce solo nelle società che non conoscono divise ed etichette. In quelle società che non sono fatte da buoni e cattivi, ma solo da uomini.