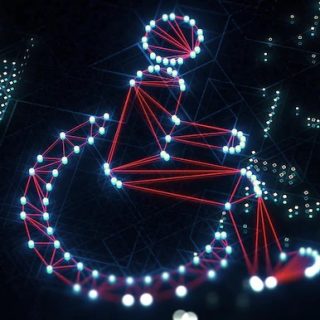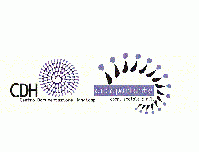di Fabrizio Pomes / In un’epoca, come quella attuale, di grandi solitudini, ripensare al periodo Covid è devastante, perché ripropone, oggi, la rottura della dimensione relazionale e fa sentire ancora viva la solitudine e, insieme, la necessità del sollievo.
Immaginiamo allora quanto tutto ciò che è stato vissuto al di fuori delle mura del carcere, sia amplificato quando si entra nella realtà detentiva. Vivere il carcere in quel periodo ha rappresentato, oltre alla privazione della libertà personale, un isolamento pressoché totale dagli affetti familiari e da quelle poche attività di formazione e di rieducazione e risocializzazione che si svolgono in tempi “normali”, aggiungendo alle rigide norme imposte dalla vita detentiva le disposizioni indotte dalla pandemia.
Eppure l’ex ministro della Giustizia, la professoressa Cartabia, al di là della indiscussa capacità professionale e dei trascorsi all’interno della Corte Costituzionale, in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente, ha da sempre parlato del suo sogno di “una giustizia dal volto umano”.
Ed è quello il sogno che ho fatto mio al risveglio, dopo una stagione minacciata dal Covid e ora finalmente alle spalle. Un sogno ancorato all’art. 27 della Costituzione che prevede espressamente che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono invece tendere alla rieducazione del condannato. Parole bellissime nelle intenzioni dei padri costituenti della Repubblica, che però per vari motivi non sono mai state messe realmente in pratica.
Il carcere oggi, per chi lo conosce e lo ha vissuto, è un limbo che non riesce né ad essere punitivo, come in passato, né tanto meno può essere considerato rieducativo. È piuttosto un contenitore nel quale chi ha sbagliato è ristretto e costretto a ciondolare per gran parte della giornata senza poter essere utile né a se stesso né agli altri.
Il carcere nel tempo è molto cambiato in simbiosi con il mutamento del mondo. E’ possibile definirlo come il riflesso speculare di una società opulenta che ha deciso di espellere i propri rifiuti, e come fa con la raccolta indifferenziata ha individuato nelle carceri la discarica più idonea. Oggi nuove forme di povertà si sono aggiunte a quelle “storiche”: i problemi psichici, le persone abbandonate, le vite vissute per strada, l’emigrazione clandestina vedono spesso il loro terminale nel carcere, sintesi pressoché ingestibile di mondi che dovrebbero essere invece attenzionati e gestiti da strutture specializzate.
Oggi il carcere è più un contenitore di marginalità sociale che un luogo di rieducazione. “È il riflesso speculare della nostra realtà sociale e una conseguenza del nostro egoismo e indifferenza sintetizzati in una cultura dello scarto. Molte volte la società, mediante decisioni legaliste e disumane, giustificate da una presunta ricerca del bene e della sicurezza, cerca nell’isolamento e nella detenzione di chi agisce contro le norme sociali, la soluzione ultima ai problemi della vita di comunità” afferma il Santo Padre. È più facile reprimere che educare. Le possibilità per i detenuti sono poche, la detenzione dinamica è ancora lontana dall’essere realizzata, i detenuti vengono aperti al mattino, possono andare all’aria ma per il resto stanno in sezione abbandonati all’ozio, in una “detenzione in parcheggio” in cui il tempo è “riempito di noia e di niente”. Al contrario un vero reinserimento sociale deve prevedere opportunità di sviluppo, di educazione e formazione, di lavoro.
Occorrerebbero meno agenti di polizia penitenziaria e molti più funzionari giuridico pedagogici, assistenti sociali, psichiatri e psicologi. Sì, perché oggi la sicurezza nelle carceri, e di riflesso fuori, ha assunto un significato diverso: è riuscire a lanciare ponti tra culture, religioni ed etnie differenti evitando di alzare muri che non risolvono i problemi ma soltanto li nascondono. Per far questo però è necessario che il detenuto venga affiancato costantemente da figure di riferimento professionalmente preparate, per costruirgli un percorso di risocializzazione e di rieducazione che, partendo dalla consapevolezza degli errori fatti, possa far intravvedere una prospettiva con rinnovato ottimismo.
In questo contesto un ruolo fondamentale lo giocano il mondo del volontariato e della cooperazione sociale che non possono, se non adeguatamente sostenuti, colmare tutti i vuoti che l’Amministrazione Penitenziaria non riesce riempire. Questa importanza è emersa con forza proprio negli anni di pandemia, durante il quale il blocco delle attività ha di fatto reso il detenuto ancor più solo e disperato. Le attività ed i corsi all’interno degli Istituti penitenziari si sono improvvisamente bloccati a causa dell’impossibilità di ingresso della società esterna, e ciò ha reso praticamente interminabili quegli anni.
Eppure la società civile è sorda di fronte alla tragedia che si consuma nelle carceri italiane e che sta creando indubbi problemi anche in riferimento ai tanti episodi di autolesionismo ed all’impennata del numero degli episodi suicidari.
Molti sostengono che “addirittura mangiano e bevono a spese nostre e hanno pure la televisione a colori” e rifiutano l’idea del carcere come di una comunità integrata con la città, e purtroppo se questi sono i presupposti il dialogo sarà sempre difficile; prova provata ne è l’indisponibilità della politica a porre in agenda modifiche sostanziali, ormai indispensabili per una reale ed efficace riforma del sistema penitenziario.