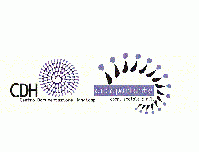Se è vero che l’Italia negli ultimi anni, a causa di una politica nana e miope, ha perso prestigio nell’ambito delle super potenze mondiali, di certo non può dirsi che abbia perso il suo storico e meritato primato quanto a fantasia.
E allora è accaduto che, anziché ragionare in termini di riforme compiute, ci si sia limitati a nascondere la polvere sotto il tappeto e a sostituire i termini con altri politicamente più corretti.
Si è iniziato a cambiare il nome agli spazzini trasformandoli in operatori ecologici, poi alle cameriere, diventate collaboratrici domestiche e, infine, ai portantini e barellieri degli ospedali subito riclassificati come operatori socio sanitari.
Anche i fallimenti della politica sono stati mistificati in tal senso. Ed ecco allora che gli Uffici di collocamento, che sono riusciti a incrociare la domanda e l’offerta di lavoro solo nell’1% dei casi, siano diventati d’incanto Agenzie per l’impiego e abbiano introdotto al loro interno figure mitologiche come i navigator il cui ruolo è pari a quello della improbabile traduzione italiana del termine.
E se gli elettori sono stanchi di essere inseguiti e vessati dalle cartelle esattoriali di Equitalia, niente di più facile che cambiarle il nome in Agenzia delle Entrate Riscossione, senza che nulla sia di fatto cambiato. Di casi ne potremmo citare tanti, ma l’interesse al cambiamento dei nomi è patrimonio di tutta la politica.
A tale logica non è sfuggito neanche il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP) che, con una sua circolare del 31.03.2017, ha imposto la ridenominazione corretta di alcune figure professionali e di altro in ambito penitenziario.
Così le celle sono diventate camere di pernottamento al fine di sfuggire alle sentenze della CEDU; lo spesino è diventato l’addetto alla spesa detenuti; il porta vitto è diventato addetto alla distribuzione pasti; il lavorante è diventato il lavoratore e così via… Stessa sorte è toccata anche alla “domandina”, quel foglietto da compilare per chiedere alla “Signoria Vostra Illustrissima” di poter partecipare a un’attività formativa, lavorativa o ricreativa, o per parlare con l’ispettore o con qualche volontario e che ora è diventato modulo di richiesta.
Questa circolare è stata oggetto di discussione e dibattito all’interno della redazione in quanto appariva come un primo segnale della volontà di voler dismettere nelle strutture penitenziarie l’uso sia verbale che scritto di una terminologia infantilizzante e diminutiva.
Abbiamo atteso invano in questi 4 anni che si completasse il processo di cambiamento del lessico e di assimilazione della vita carceraria a quella esterna.
Oggi con certezza è possibile affermare che poco o nulla è cambiato e il linguaggio del carcere, seppure avulso da quello adottato dalla comunità, non ha subito alcuna modifica.
Ma il linguaggio nella comunità carceraria ha una sua ratio e cioè il processo di infantilizzazione delle persone detenute. Se il carcere è il luogo dove si viene spogliati della propria autonomia e del proprio senso di responsabilità ciò non può che costituire la premessa della visione della persona reclusa come un bambino che gode di una libertà ridotta e di una capacità di autodeterminazione assai limitata, attraverso il rimpicciolimento del suo spazio vitale, delle sue possibilità di movimento, del suo campo visivo e del suo raggio d’azione. Ma anche attraverso quella riduzione a uno stato di minorità, imposto dalla subordinazione gerarchica e da una serie di veti e divieti.
Il vocabolario ha costituito per anni questa rappresentazione beffarda di quella condizione di minorità.
Ma lo stravolgimento terminologico più importante è forse quello legato al mondo della rieducazione, nel quale entrano in gioco le professionalità che operano in carcere, che vivono il carcere spendendo le loro capacità e competenze per l’assistenza e il recupero delle persone detenute.
Professionalità che si dovrebbero adoperare per seguire e iniziare la persona detenuta a nuove scelte, a nuove consapevolezze, finalizzate a quel cambiamento interiore che lo possa indurre, una volta fuori, a rinunciare alla devianza. Ma tale impegno si è rivelato, salvo rari, casi infruttuoso e fallimentare.
Certo la colpa è forse che voler risocializzare recludendo sia un ossimoro, insegnare a stare in società impedendogli di starci, offrire come modello sociale ottimale di convivenza la promiscuità con altri delinquenti sono clamorose contraddizioni.
E allora queste figure, per quanto preparate, operose, aggiornate, capaci, possono offrire alla persona detenuta, al massimo, degli input, delle sollecitazioni, piccoli stimoli che, qualche volta, potranno pure trovare terreno fecondo ed attecchire ma che, nella maggior parte dei casi, sono destinati a sbiadire nel pozzo stagnante del regime intramurario.
E alla luce di questi risultati, non certo incoraggianti per l’ossequio all’art. 27 della nostra Costituzione, il quale prevede espressamente che «le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono invece tendere alla rieducazione del condannato» che la politica ha pensato bene di cambiare nome a queste figure e far diventare gli educatori dei funzionari giuridico-pedagogici e quello che era il Centro di Servizio Sociale Adulti in U.I.E.P.E. (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna).
Anche quest’ultimo importantissimo, perché ha il compito principale di elaborare e sottoporre alla magistratura i programmi trattamentali, verificandone al contempo la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali misure alternative alla detenzione.
Quindi sia l’educatore che l’assistente sociale sono di fatto diventati dei burocrati ingabbiati nelle dinamiche del carcere i primi e delle regole i secondi, e il loro lavoro si è trasformato in un lavoro impiegatizio.
La cancellazione trasformazione dei nomi è figlia di una modernità liquida, leggera e fluida e, per dirla come il grande sociologo Bauman, dell’«epoca del disimpegno, dell’elusività, dell’evasione facile e dell’inseguimento senza speranza».
È una rimozione che sorge dalla distruzione del pensiero, dalla negazione degli affetti, dal sentimento della paura, dalle passioni tristi. Per dirla con un’immagine mitologica, la soppressione del nome è un furto dell’anima. La perdita del nome è la perdita di una memoria, di una storia, di una identità, di un insieme di dati e caratteristiche culturali. Perché il nome è la rappresentazione simbolica dell’identificazione e del riconoscimento.
Image’s credit: https://ling-app.com/