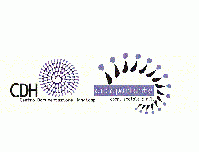di Sergio Ucciero/Domenica mattina. I preparativi fervono. Barba, un controllo al capello, i vestiti migliori. I più audaci, e fortunati, aggiungono una goccia di profumo. L’appuntamento è di quelli che, in un luogo come quello da cui vi sto scrivendo, potrei definire topico. E non manco mai di chiedermi: ma quanto di sincero c’è, quanto di vero si consuma in quelle poche decine di minuti che intercorrono tra l’inizio e la fine della funzione religiosa? Difficile la risposta. Eppure, per chi ha la ventura di entrarci, le stanze di pernottamento, come ora si chiamano con straordinaria e pomposa definizione le celle, sono tappezzate di immagini di devozione (padre Pio sugli scudi), di rosari e simboli religiosi vari che dovrebbero testimoniare una sensibilità ritrovata (o trovata) verso il sacro, l’interiorità religiosa o, per così dire, la religiosità in senso lato. E allora vien da pensare che, in qualche modo, nel mondo carcerario, l’aspra materialità della condizione spinge a una maggiore riflessione introspettiva, alla ricerca di un senso che impedisca il naufragio definitivo di chi, qualunque sia il reato commesso, cerca di raggiungere un approdo che lo mantenga a galla.
E ancora mi chiedo: ma sarà proprio così? O le immagini sono solo segni, icone, simboli che fanno parte della tradizione culturale di un popolo ma che, ormai, sono ridotti a mero fatto estetico, se non peggio, a fatto superstizioso; tanto più quando questi sono esibiti da chi, nel suo percorso criminale, già ne faceva un uso distorto, immorale e lontano dai suoi significati, come ad esempio accade nelle mafie durante i riti di affiliazione. E, a questo proposito, è interessante notare che questo uso strumentale del sacro era pane quotidiano nelle regioni del sud dove si sviluppò il fenomeno del brigantaggio sul finire del settecento e per tutto il primo decennio dell’Italia unita.
Ma torniamo al carcere. Le conversioni “sulla via della Dozza” non si contano; e non solo nel mondo cattolico romano, ma anche tra gli ortodossi, sempre più numerosi e tra gli “ospiti” di provenienza araba. Come con la messa, improvvisamente la preghiera, con tanto di chiamate dell’imam di turno, per molti scandisce il passare delle ore e il ramadan è un imperativo a cui non ci si sottrae. Per tradizione, per necessità identitaria, per non sentirsi fuori dal gruppo. E allora, per concludere questo breve scritto, mi chiedo: ma ha poi senso porsi la domanda su quanto, in carcere, c’è di vero in questo avvicinarsi al fattore religioso? O più semplicemente occorre non dimenticare il luogo, l’urgenza, il bisogno di credere che ci sia una promessa, una possibilità; che la vita non finisce dentro una cella, dietro le sbarre. È un sentimento necessario, indispensabile; mi vien da dire: semplicemente umano. E, ne sono convinto, è un sentimento che coinvolge anche chi, per missione evangelica o laica, continua, con testarda determinazione, a percorrere i corridoi delle sezioni per portare una testimonianza “antica” ma, in un mondo di esclusi, di ultimi fra gli ultimi, quanto mai contemporanea. C’è un tempo per le domande e un tempo dell’azione. Ma c’è sempre un tempo di speranza. E, in definitiva, ognuno sa quanto di autentico c’è in sé. Basta questo.