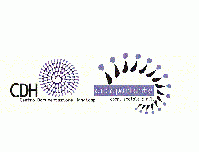di Fabrizio Pomes / Nei sistemi penali fondati sull’idea retributiva e general-preventiva, il lavoro dei detenuti era prescritto quale modalità di espiazione della pena in chiave afflittiva. Ai detenuti venivano infatti assegnate attività prive di utilità e incapaci di procurare qualsiasi forma di gratificazione.
Con la successiva concezione della funzione rieducativa della pena il lavoro detentivo si è andato invece affermando come principale strumento di recupero del condannato.
Ma anche in chiave riabilitativa il lavoro veniva dapprima concepito in uno con l’istruzione e la religione, quale strumento diretto alla modificazione della persona. Solo con la riforma penitenziaria del 1975 il lavoro acquisisce, in linea con il principio lavorista cui è informata la nostra Costituzione, titolarità come strumento di realizzazione della persona e di emancipazione sociale.
Nella disciplina vigente, abbandonata la convinzione che il lavoro sia rieducativo per se stesso in quanto rimedio all’ozio e esercizio di obbedienza alle regole, si legge che “il lavoro detentivo non deve avere carattere afflittivo, che deve essere remunerato per gratificare e responsabilizzare il detenuto, che deve essere organizzato secondo metodi che riflettano il più possibile quelli del lavoro nella società libera”. Quindi è facile dedurre che con tali affermazioni si allinei il lavoro penitenziario agli standard sovranazionali del lavoro nel libero mercato.
Ciò ha comportato anche effetti importanti sotto il profilo della remunerazione del lavoro. Nel regolamento carcerario del 1931 c’era la “mercede” quale discrezionale elargizione dell’amministrazione penitenziaria. Nel 2018 è stato finalmente introdotto il termine di remunerazione quale corrispettivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e ragguagliato alla contrattazione collettiva ancorché diminuito di un terzo rispetto ai livelli retributivi comuni. La Corte Costituzionale, investita del disallineamento retributivo rispetto al lavoro delle persone libere, ha giustificato tali differenze sulla base della minore produttività delle prestazioni dei detenuti rispetto a quelle rese dai lavoratori all’esterno.
L’abbandono della logica sanzionatoria e la configurazione del lavoro-quale trattamento equiparato a un rapporto civilistico tra un datore e un prestatore di lavoro hanno posto in evidenza il problema del riconoscimento dei diritti normalmente spettanti ai lavoratori.
Occorre però specificare che, mentre ai lavoratori detenuti impegnati con ditte esterne vengono riconosciuti tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, lo stesso non si può dire per quei detenuti che svolgono un lavoro intramurario.
È il caso per esempio dell’indennità di disoccupazione, oggi Naspi, che è ritenuta inapplicabile ai detenuti lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria per i periodi di inattività durante la detenzione o per disoccupazione conseguente alla scarcerazione.
Tutto partì dal messaggio dell’Inps del 2019 con il quale appunto si è diffusa la disdicevole prassi del mancato riconoscimento di un diritto che dovrebbe essere costituzionalmente garantito. Un vero e proprio dietrofront rispetto a precedenti decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Occorre allora che, per contrastare tale prassi discriminatoria, si faccia un ricorso gerarchico al Comitato provinciale dell’Inps per vedersi riconosciuti gli stessi diritti del cittadino libero. Pare infatti marcatamente immotivata la decisione di non riconoscere al detenuto durante l’espiazione della pena l’involontaria sospensione del lavoro, a causa della turnazione.
Solo dopo, in caso di diniego, è possibile inoltrare un ricorso al Giudice del Lavoro. Per fare tutto questo però è necessario che in tutte le carceri sia presente uno sportello di patronato che possa seguire le pratiche e le incombenze burocratiche che il detenuto ha obiettive difficoltà ad affrontare da solo. Il Covid ha infatti per due lunghi anni fatto sì che il patronato non fosse presente e ciò ha sicuramente comportato un rallentamento delle azioni di riconoscimento del diritto negato.
Una buona, seppur isolata, notizia arriva con la decisione del Tribunale del Lavoro di Venezia che nel 2020 ha accolto il ricorso contro il diniego dell’Inps al riconoscimento della Naspi con una sentenza nella quale si afferma “che la negazione del beneficio della Naspi ai soli detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria confliggerebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto accedendo all’interpretazione dell’Inps i detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria sarebbero gli unici, nell’ordinamento, a versare la contribuzione atta a finanziare la Naspi senza potersene avvantaggiare”.
Non è possibile non condividere appieno tale principio, teso a evitare figli e figliastri e le evidenti discriminazioni tra chi ha lavorato, durante l’esecuzione della pena, a favore di aziende terze avendo poi diritto alla Naspi, e chi invece ha lavorato alle dipendenze del carcere non potendo accede al beneficio.
In più il mancato riconoscimento della Naspi confliggerebbe con la stessa funzione trattamentale assegnata dal legislatore al lavoro carcerario, atteso che il sostegno economico durante il periodo di risocializzazione e reinserimento riveste un’importante valenza.
Se alla cessazione del lavoro in ragione della turnazione non fosse riconosciuta la tutela della disoccupazione anche la funzione rieducativa della pena sarebbe vanificata. È impossibile negare infatti che la disoccupazione del lavoratore sia del tutto involontaria in quanto la cessazione dell’attività lavorativa è unilateralmente stabilita dall’Amministrazione, né è in alcun modo prevedibile il momento in cui il lavoratore sarà richiamato in servizio. Sembra quindi lampante che al lavoratore detenuto privo di impiego e di stipendio per cause indipendenti dalla propria volontà, vada accordata la stessa tutela prevista contro la disoccupazione per tutti gli altri cittadini.
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e una discriminazione tra cittadini detenuti e liberi su questa materia ha una valenza simbolica nefasta che ritengo vada contrastata da una legittima ed opportuna battaglia per la promozione dei diritti.