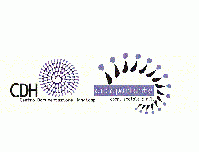di Daniela D’Avino/La parola povertà, se pensata in relazione al carcere, apre scenari devastanti.
Qui, ad esempio, ci sono tante persone che non hanno mai studiato, ma non sempre le opportunità che ci vengono offerte durante la detenzione per intraprendere un percorso di studi vengono colte. Molti privilegiano le poche possibilità di lavorare, magari si iscrivono a scuola e non proseguono, oppure non iniziano nemmeno: la povertà culturale del mondo carcerario è evidente e rappresenta una condizione da cui solo pochi riescono a riscattarsi.
Poi c’è la povertà materiale. Tante detenute devono fare i conti con risorse limitate, magari perché non hanno famiglia e in carcere riescono a lavorare solo saltuariamente. Fare la spesa qui dentro significa davvero fare i conti con la povertà, dal momento che anche acquistare beni di prima necessità per molte è un problema; a questo si aggiunge che i prezzi sono mediamente più cari che all’esterno.
Credo comunque che la povertà esistenziale sia la condizione più triste e ricorrente qui alla Dozza, come nelle altre carceri. Mi riferisco alla passività che blocca molte persone detenute e che non consente di investire in un reale percorso di rieducazione e di valorizzazione di se stessi. Spesso si cade nel vittimismo, chiedendo attenzione e aiuto senza alcuna volontà di crescere umanamente per risollevarsi da questa condizione difficile.
Concludo questa riflessione affermando comunque che anche la povertà può essere una condizione soggettiva, e cioè che dipende da come si riescono ad affrontare le difficoltà e le sofferenze; in questo contesto vedo infatti tante detenute che con carattere, forza e autostima cercano di stimolare e di motivare chi vive la stessa condizione esteriore passivamente, senza capacità di reagire e di sperare in un miglioramento di della propria vita.