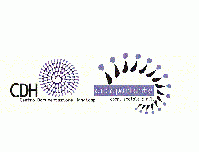di Fabrizio Pomes/Il muro rappresenta almeno due aspetti: c’è sempre un di qua e un di là, un noi contrapposto a un loro. Il muro protegge, ma al contempo divide. Come ammoniva Italo Calvino, uno dei più grandi narratori italiani del Novecento, “Se costruisci un muro, pensa a chi resta fuori!”. Spesso oltre quel muro si celano diversità e ricchezze, proprio quelle che l’indifferenza e i cosiddetti muri di gomma respingono, ignorando le richieste di aiuto, di verità e di giustizia. Il muro può essere visto come un confine dove abitano paura, terrore per lo sconosciuto e follia. Come il muro di una casa ci ripara dal freddo, allo stesso tempo ci impedisce di vedere e ci allontana dal mondo esterno, che appare incerto e fuori controllo. Invece, quel che abbiamo costruito dentro è familiare e prevedibile.
Un muro alto, grigio, che si staglia contro il cielo e spesso delimita i confini della città, con piccole finestre chiuse da possenti sbarre metalliche, racchiude un universo sconosciuto, custode di storie complicate e di anime spezzate. Oltre quel muro si trova un luogo che spesso spaventa il cittadino, ma la sua imponenza lo rassicura, facendolo sentire al sicuro.
Parlo di un luogo o, meglio, di luoghi, perché non ne esiste uno solo. Questi mi accompagnano nelle mie riflessioni del martedì, durante la rubrica “Percorsi di libertà” all’interno del palinsesto di Eduradio TV Liberi dentro. Puntata dopo puntata, cerco di addentrarmi in questi mondi, abbattendo non solo i muri materiali, ma soprattutto quelli mentali, costruendo ponti.
Gli istituti penitenziari rappresentano realtà che fin da bambini ci insegnano a evitare perché rinchiudono persone considerate il male della società. Siamo portati a credere che queste persone vengano tolte dalla strada e relegate dietro a imponenti mura per rendere il mondo più sicuro e vivibile. Vengono confinate in spazi che dovremmo evitare, ma io, pur nel mio piccolo, ho voluto superare questa barriera, realizzando un ponte fatto della mia esperienza personale di detenzione. A questo riguardo risuonano le parole del filosofo Friedrich Nietzsche: “L’uomo è una corda tesa tra la bestia e l’uomo nuovo, una corda che attraversa l’abisso. La grandezza dell’uomo sta nell’essere un ponte, non un fine”. Una metafora intensa e carica di significato, ma anche di responsabilità.
La televisione è diventata il cemento con cui ho costruito questo collegamento. Il programma entra nel carcere come uno strumento per superare la prigionia, per migliorarsi, prendere consapevolezza e imparare. Siamo convinti che, incarcerando una persona, il problema sia risolto, ma il vero lavoro inizia in quel momento. Lo scopo della trasmissione è entrare in persone diverse per cultura, età, religione, nazionalità e sensibilità, unendole in un unico percorso.
Questo strumento porta il mondo all’interno di un luogo che, di norma, ne è completamente escluso. Il mio obiettivo è dimostrare come questa pratica possa diventare uno strumento di rieducazione per chi è detenuto, aiutando nel mio piccolo a contribuire alla formazione della personalità e alla ricostruzione dell’anima. Un intervento del genere permette a chi è in carcere di regolare le proprie emozioni, di vedere con chiarezza pensieri, sentimenti, desideri e aspirazioni.
Ciò che mi ha spinto in questo percorso è la volontà di portare alla luce questo mondo a chi ancora
nutre forti pregiudizi, mostrando passo dopo passo cosa cultura ed empatia umana possono fare per un detenuto, con l’obiettivo di offrire una seconda possibilità. Il tempo della detenzione deve essere un tempo di rinascita, cura e recupero, non di esclusione.
Per me la redazione “Ne Vale la pena”, con la partecipazione di numerosi detenuti che si sono alternati in questi 13 anni di attività, e dei volontari dell’Associazione “Il Poggeschi per il carcere”, ha testimoniato come questo impegno possa trasformare la permanenza in carcere in un’esperienza vissuta con responsabilità civile, orientata alla crescita personale e alla riflessione sull’esecuzione della pena. Il recupero non deve ovviamente sostituire la pena, ma è fondamentale che la società offra a chi ha sbagliato la possibilità di cambiare.
Può sembrare difficile credere che un detenuto possa davvero cogliere l’occasione per redimersi, ma non è affatto impossibile.
Credo che la tutela dei diritti dei detenuti resterà sempre un nodo delicato per lo Stato. Nonostante la nostra Costituzione parli chiaramente di rieducazione del condannato, la quasi totalità di chi esce dal carcere dopo aver scontato la pena non si sente – e non può considerarsi – realmente rieducata.
Questo, a mio avviso, dipende dalla funzione pratica del carcere, che, invece di rieducare come
previsto dalla Carta Costituzionale, spesso spinge chi è detenuto a manifestare la peggiore parte di sé, aggravata dalle umiliazioni e dalle dinamiche che si creano dietro le mura. Alla luce di tutto ciò, sono convinto che qualcosa debba cambiare, e che questo cambiamento porterebbe benefici per lo Stato e per tutti noi cittadini.