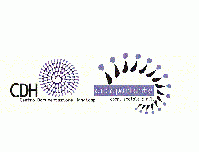di Giulio Lolli/Un evento dai risvolti unici si è svolto la scorsa settimana alla sala cinema del Carcere della Dozza in occasione del decennale della scomparsa del prof Massimo Pavarini, intellettuale, scrittore e docente presso l’Università di Bologna che ha dedicato il suo studio alla conoscenza e alla critica del sistema penale e penitenziario italiano, e del resto del mondo. Proponendo una sfida sullo stile di quelle lanciate da Massimo Pavarini, un suo ex allievo, il professor Davide Bertaccini assegnatario della cattedra di Diritto Penitenziario di Bologna, coadiuvato da due suoi ex studenti, la dottoressa Margherita Maestrelli e il dott. Lorenzo Mazza, ha deciso di dare voce comune a donne e uomini che la privazione della libertà la scontano sulla propria pelle, per far capire come prima o poi delle tante contraddizioni e ipocrisie, sofferenze e vergogne del nostro sistema punitivo se ne potrà fare a meno.
La straordinarietà dell’evento, tuttavia, non si deve solamente alla delicatezza dei temi affrontati, a una platea gremitissima o alla presenza di ospiti di rilevo come la professoressa Sofia Ciuffoletti dell’Università di Firenze (autrice di vari articoli sulle condizioni della donna all’interno del carcere) e il prof. Giovanni Torrente dell’Università di Torino (coordinatore della rivista Antigone e che ha studiato il sistema carcerario anche dall’interno svolgendo per alcuni anni la professione di educatore penitenziario) ma dal fatto che la direttrice dr.ssa Rosa Alba Casella abbia concesso, con notevole coraggio anche istituzionale, di far incontrare e permettere di lavorare assieme detenute e detenuti.
La preparazione
Un vero e proprio laboratorio culturale che nei dieci mesi di preparazione ha permesso l’incontro di saperi differenti sul controllo sociale e la giustizia penale, al quale il professor Bertaccini ha conferito il titolo scanzonatorio di “Vado al Massimo”. Sebbene durante i primi mesi di letture ed elaborazioni detenute e detenuti non hanno potuto direttamente incontrarsi, l’unione finale dei propri elaborati sulle problematiche carcerarie è avvenuto assieme, miscelando virtuosamente le esperienze dirette vissute in diversi istituti penali italiani ed esteri con le letture scelte tra i libri che il prof Massimo Pavarini ha donato in eredità al carcere della Dozza. Il fondo Pavarini è costituito da oltre 3000 tomi che hanno permesso la creazione dell’omonima biblioteca, un luogo che si staglierebbe per la sua quiete e bellezza anche se non fosse collocato all’interno di un contenitore fatto di caos e bruttura. Dopo anni di oblio, la direttrice Rosa Alba Casella ha deciso di ridare vita alla biblioteca Pavarini, rendendola punto di studio per i detenuti che frequentano l’università, luogo di confronto con i docenti e tutor e sede per corsi, incontri con le istituzioni e laboratori culturali, accessibile anche ai visitatori esterni che, con le dovute procedure e cautele, ne vogliono studiare i rari volumi.
Vari interventi
Ed è proprio grazie alle parole scritte su questi preziosi testi che le detenute e i detenuti hanno potuto esprimere con così grande intensità le proprie riflessioni, cominciate con il racconto di Hanane sulle difficoltà che incontrano le detenute straniere, e di quanto il sistema di infantilizzazione del detenuto e il metodo della “carota e del bastone” sia drammaticamente amplificato nelle sezioni femminili. Strumenti di controllo obsoleti che Pierloreto ha analizzato e criticato con profondità, chiarendo al pubblico le funzioni dell’educatore e di quanto le leggi non scritte degli attori del microcosmo carcerario, influenzino le vite dei ristretti. Vite spesso sprecate nell’ozio, come ha riflettuto Alessandra, la quale ha rimarcato la mancanza, soprattutto nelle sezioni femminili, di corsi professionalizzanti agganciati a un tirocinio che possano anticipare il contenuto di una futura misura cautelare. Ed è proprio la rieducazione il tema riportato da Igli, rimarcando che se per qualcuno, durante la carcerazione, il cambiamento in positivo avviene, per molti la detenzione provoca un mutamento pernicioso, sia morale che fisico. Elementi che evidenziano una sua personale posizione riformista, e non abolizionista, rispetto alle istituzioni penitenziarie. L’esperienza portata da Daniele ha, invece, sottolineato l’ipocrisia di un sistema che parla di rieducazione e reinserimento ma mantiene in vita la condanna al fine pena mai, una dicotomia di un’afflizione come l’ergastolo, che nega l’esistenza di se stesso con la motivazione meramente ipotetica della fruizione dei benefici penitenziari e della liberazione condizionale, che viene peraltro concessa con una media di due ergastolani all’anno.
Elementi gravi in comune
Sempre rigorosamente strumentalizzati dalla politica e dalla stampa giustizialista, di cui ha parlato chi scrive per ricordare di come sia stata più volte causa di suicidio, autolesionismo e risentimento contro le istituzioni la totale discrezionalità che la legislazione regala a Magistrati di sorveglianza, educatori e direttori delle carceri. L’esperienza di ingiustizie e discriminazione subite e viste, mi hanno fatto riportare ad alta voce le parole espresse da Massimo Pavarini che nel suo Manifesto, redatto oltre 20 anni fa, le quali risuonano oggi più che mai attuali: “E allora, in favore del carcere non c’è difesa possibile, neppure la più radicale delle riforme impossibili. A chi sdegnato allontana lo sguardo dal supplizio, non resta che agire per abolire quel supplizio.”
L’ultimo intervento
L’ultimo intervento è stato di Naomi e, sebbene tutte le donne hanno mostrato come la sensibilità del genere femminile sia una ricchezza sempre troppo trascurata, il suo ha colpito i presenti non solo per i temi trattati, ma per l’intensità emotiva che ha saputo trasmettere.
Sovrapponendo le letture di Recluse di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa e La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza di Sandra Rosetti alla sua esperienza di vita, Naomi ci ha raccontato dei conti che ha dovuto fare con uno Stato inefficiente, sia per mancanza di leggi sia per la mentalità maschilista e patriarcale di chi aveva il compito di tutelarla in quanto cittadina, e, poi, di come quello stesso Stato l’abbia giudicata e abbandonata in un carcere. Un luogo dove ha incontrato nuovamente quel sistema patriarcale che ha cercato di infantilizzarla, trattandola come una incapace nonostante abbia tirato su da sola una figlia splendida e mostrato capacità manageriali di assoluto rilievo, grazie alle quali si è trovata un lavoro che le permetterà a breve una meritata ripartenza.
Conclusioni
Storie che sarebbero rimaste senza racconto se non ci fosse stata un’iniziativa che meriterebbe di essere riproposta, non solo per rendersi conto che nelle carceri esiste un’umanità e una cultura ben diversa e migliore di quella che ci racconta una classe politica che ha sostituito i libri con gli smartphone e il dibattito parlamentare con i post su Instagram, ma anche che il muro, non fatto di cemento ma di morale sessista e patriarcale che separa uomini e donne nelle carceri, può essere abbattuto.