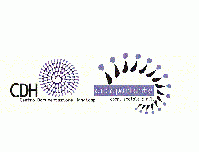di Alex Frongia/Il sistema penitenziario italiano è regolato da una solida normativa che si ispira ai principi costituzionali di umanità e rieducazione. Tuttavia, deve quotidianamente confrontarsi con una complessa realtà di sovraffollamento, disuguaglianze territoriali e criticità strutturali. In questo contesto, la questione del trasferimento tra istituti penitenziari emerge come un aspetto cruciale, spesso sconosciuto all’opinione pubblica, ma di enorme importanza per la vita dei detenuti. La presunta fluidità del sistema nasconde un processo che, se gestito in modo arbitrario e improvviso, può trasformarsi in un’ulteriore, ingiustificata afflizione.
Il carcere, a differenza della percezione comune, non è un luogo fisso e immutabile. I detenuti possono infatti essere trasferiti per molteplici ragioni: esigenze di giustizia, come l’avvicinamento alla famiglia, motivi disciplinari, necessità sanitarie che richiedono cure specialistiche non disponibili nell’istituto di appartenenza, problemi di ordine e sicurezza, o semplicemente per la cronica mancanza di posti in determinati istituti. Al di là dell’apparente neutralità del procedimento, i trasferimenti incidono profondamente sulla quotidianità del detenuto, sul suo stato psicologico, sulle sue relazioni familiari e sul percorso riabilitativo intrapreso. Rappresentano, in un certo senso, una “seconda pena”, spesso vissuta come un trauma e un forte sradicamento.
Il trasferimento è sempre un evento improvviso ed inaspettato e per questo costituisce un trauma, un punto di rottura col vissuto che faticosamente chi sconta una pena si costruisce giorno per giorno. Non di rado, il detenuto viene informato del trasferimento pochi minuti prima di partire, senza avere il tempo di raccogliere gli effetti personali o di avvertire i familiari. Questa mancanza di preavviso e di dignità si aggiunge alla precarietà del trasferimento stesso, spesso effettuato con i cosiddetti “cellulari”, furgoni blindati dotati di gabbie anguste dove si fa fatica a respirare. Una condizione, questa, che non solo è degradante, ma rappresenta anche una chiara violazione dei principi di umanità sanciti dalla Costituzione.
Il trasferimento dovrebbe essere programmato, motivato e, ove possibile, concordato con il detenuto, non imposto in maniera unilaterale. Una vera politica di mobilità penitenziaria deve tenere conto della persona, delle sue relazioni e del suo progetto di vita, evitando di considerare il detenuto come un semplice “numero da spostare” o, peggio, un “pacco postale”. Un simile approccio disconosce la finalità rieducativa della pena, trasformando l’istituzione carceraria in un luogo di mera detenzione, privo di prospettive di reinserimento.
Occorre, dunque, una riflessione sistemica che metta al centro la persona detenuta, riconoscendo il suo diritto alla stabilità, alle cure e alla dignità. È fondamentale investire in procedure che garantiscano il rispetto dei diritti, un’adeguata comunicazione e la possibilità di mantenere i legami familiari. Solo in questo modo il trasferimento potrà smettere di essere un trauma e diventare, al contrario, una tappa razionale e funzionale del cammino verso il reinserimento e la libertà, in linea con i principi che la nostra Repubblica si è data.